
L’incontro di Dante con un’anima dannata ancora abbracciata al suo peccato.
Nella Commedia dantesca, la bellezza di cento canti con una media di circa centoquaranta versi l’uno, per un totale di quattordicimiladuecentotrentatre versi, le donne che parlano con Dante, in un universo maschile di peccatori, penitenti e beati, sono cinque, soltanto cinque. Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei, Sapia, Piccarda Donati, Cunizza da Romano. Beatrice, per la sua preminente funzione simbolica, meriterebbe un discorso a parte; in questo e negli articoli che seguiranno l’oggetto delle riflessioni saranno quindi le cinque figure sopra elencate.
Innanzitutto; come mai solo cinque? C’è da stupirsi? Considerato che Dante è uomo del suo tempo, il milletrecento, del quale incarna valori, pregiudizi e passioni politiche, nonostante il suo sguardo sul mondo attinga ovviamente anche all’universale ed al trascendente, direi proprio di no. Quindi mi sembrerebbe antistorico e pretestuoso scandalizzarsi dell’esiguità del numero delle interlocutrici dantesche, ancora di più considerando la Vita Nova e le tante canzoni dell’autore dedicate proprio alle donne; ma questo è un argomento complesso che meriterebbe una trattazione a parte.
Passerei dunque ad esaminare il primo di questi cinque incontri.

Cominciamo con Francesca da Rimini, la cui storia all’epoca fece scalpore e salì agli onori della cronaca per la violenza dei fatti e la celebrità dei protagonisti.
Francesca, figlia di Guido da Polenta, signore di Ravenna, andò sposa a Gianciotto Malatesta, signore di Rimini, uomo deforme e zoppo, per motivi politici e diplomatici. Il matrimonio doveva sancire la pace tra i casati dei Malatesta e dei Da Polenta. E così Francesca si ritrovò a Rimini, nel castello dei Malatesta, spesso sola per le lunghe assenze del marito e possiamo immaginare ben lontana dall’essere felice. A corte viveva anche il fratello più giovane di Gianciotto, Paolo Malatesta, bello, colto ed intelligente. Francesca s’innamorò di Paolo e i due, scoperti da Gianciotto, vennero uccisi insieme. Questi i fatti; ma da quel truce delitto Dante trae spunto per scrivere terzine indimenticabili, alla base di tanta poesia d’amore.
L’incontro avviene nel quinto canto dell’Inferno: ci troviamo nel girone dei lussuriosi, puniti in un luogo buio e funestato dal rumore del mare in tempesta, travolti e percossi da una feroce bufera infernale che non si ferma mai. Qui sono puniti, appunto, i lussuriosi, coloro che hanno sottomesso la ragione al piacere e meritano quindi, secondo il pensiero cristiano medioevale, la punizione eterna. Dante, davanti a tanta pena, davanti alla vista di celebri peccatori come Semiramide, Cleopatra, Elena di Troia, Paride e Tristano, un gruppo dove anime di uomini e donne realmente esistiti si mescolano con personaggi mitici e della tradizione cavalleresca, dice che “pietà mi giunse e fui quasi smarrito”. Siamo solo all’inizio del viaggio di Dante all’Inferno, ma l’autore aveva già visto la sofferenza dei dannati trasportati da Caronte, gli ignavi sotto i loro massi, ma non aveva provato “pietà” per loro, né gli accadrà spesso di provare tale sentimento per altri peccatori. Tra le anime sballottate con violenza dalla “bufera infernal, che mai non resta,” Dante è attirato da “quei due che’insieme vanno, /e paion sì al vento esser leggieri”. Le due ombre colpiscono l’autore perché sembrano soffrire ancora di più per la violenza della pena a causa della loro leggerezza e soprattutto perché sono abbracciate, a dimostrare che il loro amore continua, anche all’Inferno, anche nella pena eterna. Anzi Virgilio consiglia a Dante di pregare le anime di fermarsi “per quello amor che i mena”, a sottolineare che è l’amore che ancora provano l’uno per l’altra, quindi la loro colpa, a travolgerli, più che la bufera infernale. Il dialogo tra Dante e Francesca ha luogo perché l’anima accetta volentieri l’invito di Dante a parlare con lui, cogliendo un attimo di misteriosa pausa del feroce vento che li punisce. L’anima si rivolge al pellegrino dell’aldilà con la dolcezza e la cortesia di una castellana del trecento, sensibile e colta: apprezza la “pietà” per loro che intuisce in lui e lo ringrazia. Più avanti, quando Dante le chiederà di raccontare come lei e Paolo furono spinti all’adulterio, “al doloroso passo”, risponde usando una formula di Severino Boezio : “nessun maggior dolore/ che ricordarsi del tempo felice/ ne la miseria”. Gli racconta di essere nata a Ravenna e poi passa subito alla vicenda dell’amore tra lei e Paolo nelle tre celeberrime terzine che tutti ricordiamo:
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense».
Queste parole da lor ci fuor porte.
L’amore di cui parla Francesca è l’amore dello Stilnovo, quello che può nascere solo in un cuore “gentile”, cioè di nobili sentimenti (Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende”) e non può che essere ricambiato dall’amata, inevitabilmente scelta perché ha un cuore altrettanto nobile ( “Amor, ch’a nullo amato amar perdona”). Qui si parla solo dell’amore tra Paolo e Francesca. A Gianciotto è dedicata solo una constatazione, secondo alcuni una maledizione: “Caina attende chi a vita ci spense”.

Francesca è una donna colta, dicevamo; quando Dante le chiede quale sia stato l’inizio del loro amore, Francesca risponde con una frase virgiliana:
Ma s’a conoscer la prima radice
Del nostro amor tu hai cotanto affetto,
dirò come colui che piange e dice.
Più o meno le stesse parole di Enea a Didone che gli chiede di raccontare la fine di Troia e la sua fuga dalla città:
Ma se è tanto l’amore di conoscere le nostre vicende,
di udire in breve l’estrema angoscia di Troia,
nonostante l’animo inorridisce al ricordare e rifugge dal tutto, inizierò.
E anche l’occasione in cui i due amanti, ancora inconsapevoli del loro sentimento, si accorgono di amarsi è legata alla letteratura, questa volta alla lettura di un romanzo cortese, la storia di Lancillotto e Ginevra.
Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.129
Per più fïate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.132
Quando leggemmo il disïato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,135
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante”.138
Mentre Francesca racconta la sua storia, Paolo piange. Non dice una parola. E la pietà di Dante verso i due peccatori è tale che perde i sensi.
Dunque la prima donna che parla nella Commedia dantesca è una peccatrice, certo, almeno secondo la morale dell’epoca, ma anche, e prima di tutto, una donna innamorata, costretta ad un matrimonio politico con un uomo deforme e poi da lui uccisa. Una vittima delle convenzioni, diremmo oggi; il suo assassinio, un femminicidio.
Chi volesse ascoltare la storia di Paolo e Francesca dalla voce della straordinaria attrice Lucilla Giagnoni può utilizzare il link sottoriportato.
Lucilla Giagnoni – Paolo e Francesca (Vergine Madre – Divina commedia) – Bing video
© 2024 CIVICO20NEWS – riproduzione riservata
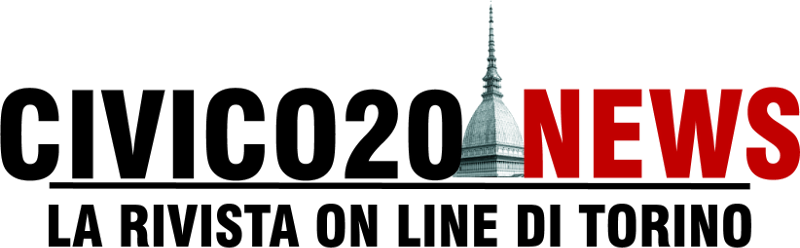







2 thoughts on “Le donne nella Commedia dantesca: Francesca da Rimini”